Erasmo da Rotterdam – Part. 5: Commento all’adagio ” Dulce Bellum Inexpertis”
025/01/18, Vergato – La Pace in Erasmo da Rotterdam: Commento all’adagio ” Dulce Bellum Inexpertis” e alla “Querela Pacis”
La storia si ripete? Guerre, morti, distruzione… pace! Leggiamo la quinta parte dell’introduzione a un percorso che viene dal passato ma parla del presente.
Uscita a puntate. Hai perso le puntate precedenti? Clicka qui: Portami alle puntate precedenti
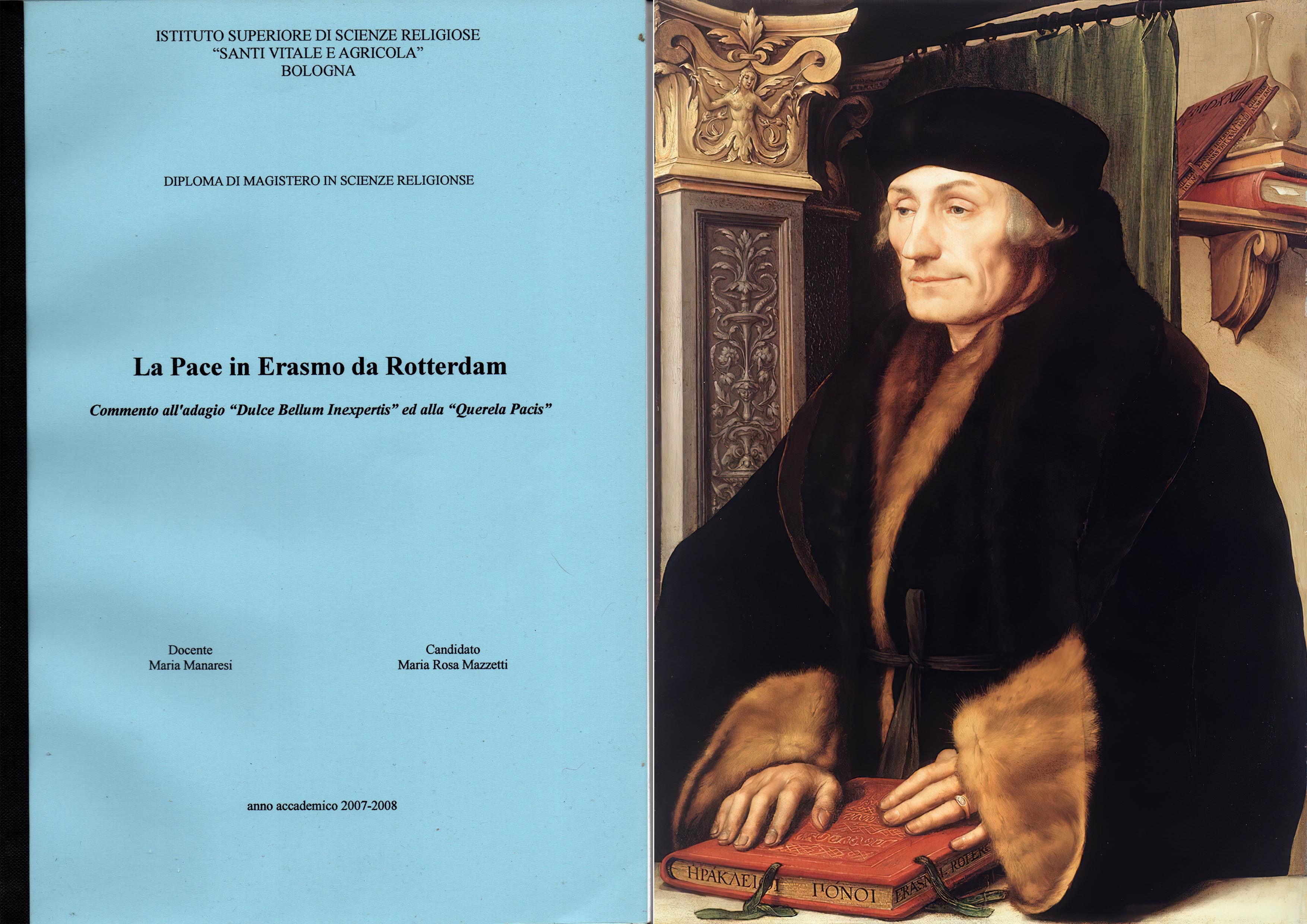
5° – Puntata – Cap. 3 – Adagio “Dulce bellum inexpertis” (Dolce è la guerra a chi non l’ha provata)
Erasmo parte da una concezione ottimistica: la natura non ha creato l’uomo per la guerra anzi, essa è un’aberrazione il prodotto di una malattia dello spirito che il cristianesimo dovrebbe aver sanata ed è nello stesso tempo la rinuncia alla razionalità è una scelta antieconomica per risolvere i problemi della convivenza umana. Vi sono dunque nel pensiero erasmiano due aspetti essenziali :
- la predicazione di una vita cristiana secondo l’esempio di Gesù
- un appello alla ragione e civiltà
L’adagio “Dulce bellum inexpertis” fu scritto nel 1515.
Nell’edizione degli adagi del 1508 esso è brevissimo, conta di sole cinque righe e tale resta nelle successive edizioni sino a quella di Froben del 1515, nella quale assume un’ampiezza notevole: 1000 righe.[1]
Vi furono aggiunte successive nell’edizione del 1523 e 1526. La forma definitiva è del 1536. Non si tratta di uno scritto di occasione come è di solito l’opera di Erasmo, ma cerca di elaborare una dottrina generale della pace e della guerra. Per Franco Gaeta[2] l’adagio che, dalla esigue brevità della prima edizione cresce continuamente è il testo principe anche se non il più noto, del pacifismo erasmiano, perché non nasce – neppure nella struttura delle progressive aggiunte – da circostanze occasionali , ma da una costante e impegnata meditazione, la quale porta non soltanto a spiegare storicamente le origini del fenomeno guerra, a deprecarlo nella sua genesi e nelle sue conseguenze e a condannarlo radicalmente in nome della ragione evangelica, ma ad indicare anche i rimedi che gli si possono opporre e le vie per le quali se ne può procurare la scomparsa.
E’ un testo che è venuto progressivamente crescendo sotto l’impulso di un’assidua meditazione. Non si può chiedere ad Erasmo un programma esclusivamente o prevalentemente politico perché egli, come ogni pacifista, ha sempre in testa un pizzico di illusione e di utopia che sta nell’immaginare la possibilità che la pace possa non solo essere perpetua, ma fondata in ragioni che superano la sfera politica e si ritrovano nella coscienza morale dove la consapevolezza di un rischio civile totale può rendere effettiva la possibilità di una rinuncia alla guerra.
Non esisteva nel XVI secolo questo rischio totale, né la consapevolezza di un pericolo radicale, ma c’era in Erasmo la coscienza di un pericolo per lui non meno grave, cioè di una corruzione eversiva del messaggio evangelico, che aveva un’ampiezza vastissima, la quale abbracciava la dottrina, la pratica, l’essenza stessa della vita cristiana.
L’opposizione tra la philosopia Christi e la guerra è per Erasmo viscerale. Dice Erasmo nell’Adagio Dulce Bellum Inexpertis[3] “Un solo animale io ho generato [è la natura che parla] all’amorevolezza, alla dolcezza, all’amicizia e al soccorso, cosa è avvenuto perché egli degenerasse sino a questo grado di ferocia? Non riconosco in nulla l’uomo che ho formato. Quale genio malvagio ha corrotto l’opera mia? Quale strega ha estirpato dall’uomo, con un sortilegio, lo spirito umano e gli instillato con arte magica l’istinto belluino?……. Vorrei che il disgraziato si guardasse allo specchio; …..Da dove ti viene mai questo pennacchio minaccioso sulla testa? Da dove quest’elmo luccicante con le sue corna minacciose? ….questa voce più feroce di quella delle belve? E questo sguardo più che selvaggio?……Io ti ho formato a guisa di un essere in certo modo divino: cosa ti è venuto in mente di trasformarti in una bestia tanto feroce che ormai nessuna belva potrà sembrare una belva se la si paragonerà all’uomo?”
Infatti Erasmo afferma[4] che la maggior parte degli animali non ragionevoli, nell’ambito della propria specie vivono in concordia ed in armonia e neppure gli animali che vivono allo stato selvaggio combattono tutti (ce ne sono infatti di innocui come i daini e le lepri), ma solo i più feroci come i leoni, i lupi e le tigri.
E neppure questi fanno la guerra tra simili come facciamo noi: il cane non mangia carne di cane, i leoni non si assalgono tra loro ecc. Per l’uomo nessuna fiera è più pericolosa e dannosa dell’uomo. Almeno gli animali selvaggi quando combattono, combattono con le loro armi naturali; noi invece violando l’ordine della natura, armiamo gli uomini a danno l’uno dell’altro, con le armi escogitate dall’arte di geni malefici.
Gli animali selvaggi non incrudeliscono per una qualsiasi ragione, ma o perché la fame li rende rabbiosi, o perché si vedono assaliti, o perché temono per i loro nati. Invece per quanto frivoli motivi, quali tragedie di guerra noi provochiamo!
Quindi Erasmo si chiede, dal momento che l’uomo è stato creato come s’è detto (cioè per l’amorevolezza, la dolcezza, l’amicizia e il soccorso) cosa ha generato nel cuore dell’uomo il desiderio “immergere un ferro mortifero nelle viscere di un altro uomo”. A questo genere di pazzia si deve essere arrivati per molti gradi. E qui spiega storicamente le origini della guerra. Dice infatti:[5] “ un tempo gli uomini primitivi che vivevano nelle selve, nudi senza case e senza mura deve essere accaduto che fossero assaliti da bestie feroci.
Con queste per la prima volta gli uomini fecero guerra e fu riconosciuto capo chi fosse stato capace di proteggere la specie umana dalla violenza delle fiere. Sembrò assolutamente giusto sgozzare chi sgozzava, trucidare chi trucidava perché gli animali feroci assalivano gli uomini senza essere stati né provocati né offesi. Queste azioni furono esaltate e quindi di Ercole se ne fece un dio; così i giovani coraggiosi cominciarono a dare la caccia alle bestie e ad ostentarne le spoglie come trofei. In seguito, non contenti di averle uccise si protessero con le loro pelli contro i rigori dell’inverno.
Queste furono le prime uccisioni e le prime spoglie.”
Poi Erasmo continua dicendo che vi fu un passo ulteriore uccidere il padre vecchio e gettarlo in una fossa considerandolo un atto di pietà e infine cibarsi delle carni dei più intimi amici oppure fare prostituire una vergine nel tempio di Venere e mille altre cose ancora più assurde. Così si cominciò a cibarsi delle carni dei cadaveri delle bestie uccise. Poi dagli animali nocivi si passò a quelli innocui: buoi, ovini, lepri, porci , uccelli ecc… Quindi l’uomo abituato ad uccidere gli animali fu spinto dall’ira ad assalire i suoi simili, col pugno, col sasso, con la clava. Questa crudeltà fu contenuta in un primo tempo nella forma di duello.
Le guerre si risolvevano col sacrificio di uno dei due contendenti. Togliere di mezzo il nemico aveva poi un’apparenza di equità. In un secondo tempo ci si unì in gruppi a seconda della parentela , della vicinanza, della amicizia e ciò che ora si chiama assalto brigantesco fu allora la guerra. Si combatteva allora con sassi e bastoni e un qualunque ostacolo: un fiumiciattolo da guadare o una rupe da superare metteva fine alla lotta. Ma poi mentre cresceva la ferocia gli uomini “armarono con la propria intelligenza il loro furore”[6] .
Si inventarono così le armi per difendersi e armi d’offesa per uccidere i nemici. “Gli uomini cominciarono a scontrarsi in armi di qua e di là ed in bande sempre più numerose; e a questa manifesta pazzia non mancò il debito onore: la chiamarono guerra e decretarono che il coraggio consisteva nel respingere, rischiando la vita, la violenza esercitata dal nemico contro i propri figli, la propria moglie, il proprio gregge la propria dimora”[7].
E così un passo alla volta una città dichiarò guerra ad un’altra , una regione ad un’altra e un regno ad un altro. Però c’era ancora qualche segno, secondo Erasmo, dell’antica umanità: non si poteva assalire il nemico senza avere prima dato il segno del combattimento o dopo che il comandante avesse dato la ritirata. Ed allora si combatteva più per mostrare il proprio valore che per uccidere. E si combatteva solo contro gli stranieri, così si formarono gli imperi che sorsero a prezzo di molto sangue umano. Da questo momento cominciò un’assidua vicenda di guerra: ognuno cacciò un altro dal potere. Non si lottò più per la gloria, ma per lucro. Per questo, continua Erasmo, Pitagora dissuadeva gli uomini da uccidere gli animali, perché colui che vi si era abituato non avrebbe poi esitato ad uccidere un essere umano.
“ E la guerra cos’altro è se non un assassinio plurimo e reciproco, ed un atto di banditismo, tanto più scellerato quanto più praticato su vasta scala?”[8]
Ma continua Erasmo “I potenti irridono a queste riflessioni ritenendole fantasticherie, quei potenti che di uomini non hanno altro che l’aspetto e si credono senz’altro dei”[9]
Così tutti combattono contro tutti : nazioni contro nazioni, parenti contro parenti, consanguinei contro consanguinei, fratelli contro fratelli, figli contro padri. Ma per lui la cosa più atroce è che i cristiani combattano altri uomini e cosa più “abominevole” i cristiani guerreggiano contro i cristiani, senza che nessuno ne provi orrore. La cosa poi ancora peggiore per Erasmo è che siano i monaci, i preti ed i teologi a fare discorsi bellicosi, chiamando in causa Cristo in un affare tanto diabolico. Si combatte sotto il segno della croce ed in una azione tanto empia si rende Cristo garante e spettatore.
Ed Erasmo continua chiamando in causa l’apostolo Paolo che si sdegna quando i cristiani fanno intervenire un magistrato per dirimere una contesa.[10]
Cosa direbbe, si chiede Erasmo, se ci vedesse combattere in tutto il mondo per i più futili motivi più crudelmente dei barbari e più ferocemente dei pagani, dietro l’esortazione e con la complicità di coloro che rappresentano Cristo?
Come si è paragonato l’uomo essere pacifico con la guerra : la cosa più brutale, così ora Erasmo lo paragona con la pace. “Cosa c’è”, dice “ di meglio dell’amicizia?”
“Nulla , sicuramente e la pace è la reciproca amicizia fra un gran numero di persone. Mentre la guerra è un’avversione generale. Continua, poi[11] affermando che la caratteristica delle cose buone è che più si diffondono e più vantaggi recano, quindi quale felice condizione vivrebbe il mondo se i regni e le nazioni fossero legati dal vincolo dell’amicizia! E all’opposto le cose malvagie, più si diffondono e più malvagie sono, se dunque e una scelleratezza che un uomo combatta un altro con le armi, quanto maggiore sarà la calamità che a combattere siano tante migliaia di uomini! Conclude poi la descrizione dei benefici della pace e dei mali della guerra dicendo:
“Nella guerra noi subiamo una quantità di mali che nessuno può descrivere adeguatamente e tanto meno io.
Forse si potrebbe tollerare che la guerra ci rendesse soltanto infelici, ma non anche empi e malvagi, se la pace soltanto felici e non anche migliori”[12] . La guerra, per Erasmo, attira sugli esseri umani che già sono esposti ad innumerevoli calamità un malanno “così orribile e rovinoso da vincere lui solo ogni altro”[13] e al contrario della pace non finisce mai così felicemente che un vincitore, dotato di senno, non si penta di averla iniziata. Se la pace è la più amabile e la migliore di tutte le cose, la guerra al contrario è la più miseranda e la più funesta, quindi non sono da ritenersi sani di mente coloro che potendo procurare la prima con poca fatica, preferiscono provare la seconda anche con grandissime difficoltà.
Poi Erasmo parla della scomodità della vita militare concludendo “Tutti questi disagi si sopportano per arrivare poi a trovarsi nella condizione più infelice, e con questi così grandi mali noi affliggiamo prima noi stessi per poter poi affliggere gli altri”[14]. C’è poi un discorso economico sul costo della guerra molto superiore a quello della pace non solo in spese, ma anche in affanni, fatiche disagi e sangue. Infine l’assurdità che i cristiani fratelli in Cristo uniti da un vincolo più forte di quello dei fratelli di sangue combattano fra di loro.
Per Erasmo se si considera la dottrina cristiana (cioè il Vangelo) non c’è nulla che non ispiri pace che non suoni amicizia e non abbia il sapore della carità. E poiché la pace non può sussistere se non si disprezzano i beni per cui il mondo combatte, Cristo ci insegnò ad imparare dal suo esempio ad essere miti. Egli ha chiamato beati coloro che disprezzano la ricchezza e la superbia e li ha definiti poveri di spirito, ha chiamato beati coloro che disdegnano i piaceri del mondo indicandoli come coloro che piangono e ancora beati coloro che si lasciano spossessare di quanto possiedono senza reagire, perché sanno che sulla terra non c’è che esilio e la vera patria è quella celeste.
Ha chiamato beati coloro che, mentre beneficano tutti, vengono calunniati e perseguitati, ha proibito di resistere ai malvagi. Tutta la sua dottrina insegna dunque tolleranza e amore e tutta la sua vita mansuetudine. Così Cristo ha regnato, combattuto, vinto e trionfato e questo hanno cercato di inculcare gli apostoli. Pace, dolcezza e carità insegnano Paolo, Giovanni e Pietro. Da dove viene dunque la guerra fra i figli della pace?
Per Erasmo tutto l’insegnamento di Cristo sarebbe stato contaminato dalle idee dei dialettici, dei sofisti, dei matematici, degli oratori, dei poeti dei filosofi pagani e anche dalla ricezione delle leggi romane e noi, per l’equità di cui esse fanno mostra e perché la concordanza fosse più stretta, abbiamo distorto fin dove è stato possibile la dottrina evangelica verso il loro spirito. Ma le leggi romane permettono di respingere la violenza con la violenza, di far valere ciascuno il proprio diritto, approvano i traffici, consentono di praticare l’usura, sia pure entro certi limiti, esaltano la guerra come azione eccellente se si tratta di guerra giusta e definiscono giusto ciò che è stato ordinato dal principe. In realtà noi trascorriamo la maggior parte della nostra vita, prima di poter meditare le Sacre Scritture e quando lo facciamo, siamo così corrotti da tante opinioni profane che i precetti di Cristo o sono motivo di scandalo o vengono interpretati distorcendo il senso delle loro massime.
Per Erasmo abbiamo cercato di far concordare la dottrina di Cristo con la saggezza dei filosofi, per cui abbiamo, in un primo momento, ammesso la gloria poi in qualche modo la ricchezza dapprima approvata a patto che si distribuisse ai poveri, poi anche per servircene a nostro vantaggio e abbiamo anche imparato che il giusto ordine della carità e ritenere se stessi, il proprio prossimo ed Erasmo elenca i pretesti: provvedere ai figli e, in anticipo, alla vecchiaia.
“E infine” – continua Erasmo- “perché rinunciare alla ricchezza se ce la possiamo procurare onestamente?
Un passo alla volta poco a poco, si è arrivati al punto di ritenere migliore chi è più ricco: mai tra i pagani le ricchezze ebbero maggiore importanza di quanta ne hanno oggi tra i cristiani. Cosa c’è infatti di sacro e di profano che non sia a discrezione del denaro?”[15]
Alla gloria ed alla ricchezza Erasmo aggiunge anche il potere , e qui parla del potere civile esercitato dai vescovi e dagli abati. Poi Erasmo ritorna al tema che gli sta a cuore dicendo “Quando mai tra i pagani si guerreggiò altrettanto continuamente e altrettanto crudelmente di come avviene tra i cristiani? Quali sconvolgimenti e quali bufere di guerra, quali stragi e quali violazioni di patti non abbiamo visto in questi pochi ultimi anni?”[16]. Secondo Erasmo anche gli antichi eroi come Serse che aveva invaso la Grecia e aveva ordinato di flagellare l’Ellesponto perché non era stato troppo favorevole alla sua navigazione, o Alessandro Magno che desiderava esistessero più mondi per poterli sottomettere tutti, tanto la sua smania di gloria era grande, erano pazzi, però combattevano più umanamente, non con queste macchine da guerra, e non con questi frivoli pretesti con cui invece combattevano i cristiani, suoi contemporanei.
Ciò che più lo scandalizza è proprio che i cristiani combattano con metodi tanto brutali e tra di loro. Infatti dice “comunque noi esprimiamo, anzi superiamo, quanto di peggio vi era tra i pagani”[17]
Porta poi l’esempio degli Ebrei e dice “Agli Ebrei fu permessa la guerra, ma allo stesso titolo per il quale fu concesso loro di poter ripudiare la moglie: per la durezza della loro mente. Dopo che Cristo ha ordinato di ringuainare la spada, i cristiani non possono però più combattere se non la bellissima guerra contro i più turpi nemici della Chiesa: contro l’avidità del denaro, contro l’iracondia, contro l’ambizione, contro la paura della morte. Sono questi i nostri Filistei, i Nabucodonosor, i Moabiti e gli Ammoniti, con i quali non possiamo avere tregua, con i quali dobbiamo sempre combattere, finchè annientati i nemici, non subentri la tranquillità. Finchè non avremo soggiogato questi avversari nessuno potrà avere pace né con se stesso né con gli altri. Questa guerra soltanto genera la pace: chi la vincerà non vorrà più combattere contro nessun uomo.”[18]
Anche Pietro si era sbagliato, e aveva sfoderato la spada, ma Cristo ordinò di rimetterla al suo posto proprio perché a nessuno potesse rimanere il dubbio che non fosse vietata la guerra che prima era ritenuta lecita. Cristo quindi non approva questo tipo di difesa infatti invita i suoi discepoli ad affrontare i tiranni, armati soltanto del bastone e della bisaccia. E qui Erasmo polemizza con quelle interpretazioni che permettono ai cristiani di combattere perché “il dotto veramente cristiano non approva mai la guerra forse qualche volta la permette, ma suo malgrado e con dolore”[19]. Continua, poi dicendo che non si può respingere la violenza con la violenza nemmeno per difendere la propria vita o il proprio denaro anche se questo è imposto dal diritto naturale, approvato dalle leggi e recepito dal costume perché la grazia evangelica ordina di non maledire chi ci maledice di beneficare chi ci danneggia e di dare tutti i nostri averi a chi ce ne vuole prendere una parte e di pregare per chi ci perseguita a morte e questi precetti riguardano tutti i cristiani perché sono il corpo di Cristo cioè il suo popolo, coloro che sperano di ottenere il premio della risurrezione e dell’immortalità assieme a Cristo.
Costoro non desiderano né la ricchezza né i beni di questo mondo e sanno che questa è piuttosto morte che vita, quindi non combattono per difendere questa vita. Poi Erasmo cita l’esempio di alcuni pontefici romani, alludendo a Giulio II, che furono suscitatori di guerra o ad alcuni padri della Chiesa che sembra approvino la guerra, ma dice occorre rifarsi all’autorità di Cristo e delle scritture. Per quanto riguarda i pontefici dice che essi furono prima di tutto degli uomini e perciò possono essere stati mal consigliati, poco scrupolosi, o poco prudenti e infine poco dotati di spirito religioso. Per quanto riguarda i padri della Chiesa, dice che si tratta di pochissime massime e di padri piuttosto recenti che vissero in un tempo in cui il rigore della dottrina di Cristo già si era affievolito. Insiste poi sull’ingiustizia della guerra che colpisce chi meno se lo merita, cioè i bambini, i vecchi, le donne, le persone cioè più innocenti.
E’ meglio quindi lasciare impunita la colpa di qualcuno piuttosto che punire con una guerra tanti innocenti sia tra gli amici che tra i così detti nemici. Si lamenta dei futili motivi per cui si faceva la guerra: i diritti dei principi o le loro alleanze. Diritti per cui non valeva la pena combattere a prezzo di sciagure così grandi per i propri sudditi. Ribadisce perciò il concetto che mettendo sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi, si trova che una pace iniqua è molto più conveniente di una guerra giusta. Propone di risolvere le contese dei principi con l’arbitrato di persone sapienti quali vescovi, abati, nobili anziani ecc.
Per quanto riguarda coloro che poi vorrebbero difendere la Chiesa attraverso le armi ricorda che la Chiesa è sorta e si è sviluppata non con guerre e massacri, ma con il sangue dei martiri. E in questo testo parla poi della guerra che si stava preparando contro i turchi dicendo: “A me sembra non si debba approvare neppure la guerra che prepariamo contro i Turchi. La religione cristiana è davvero a mal partito se la sua salvezza dipende da queste difese; cominciando così, non si creano certo buoni cristiani. Ciò che si conquista col ferro, col ferro si perde.”[20]
I Turchi devono vedere degli esempi di cristiani non soltanto di facciata, ma con le caratteristiche genuine dei seguaci di Cristo che sono: la vita irreprensibile, il desiderio di fare del bene anche ai nemici, l’incrollabile sopportazione di tutte le offese, il disprezzo del denaro, il disinteresse per la gloria , la poca considerazione per la vita (intendendo naturalmente la propria esistenza fisica). Queste sono le armi che Erasmo propone per sottomettere anche i Turchi. E continua affermando che trucidare gli infedeli non è un’azione da cristiani perché essi sono degli uomini per cui Cristo è morto, nello stesso modo non si comportano da cristiani coloro che con esecrazioni credendosi ortodossi consacrano all’inferno gli eretici, invece di cercare di riportare con pacati ragionamenti chi erra a ricredersi, questi sono per Erasmo più degni del nome di eretici.
“Noi sputiamo sui Turchi e così ci sembra di essere magnifici esemplari di cristiani, e siamo invece, forse più abominevoli presso Dio dei Turchi medesimi”[21]. Continua dicendo che se gli antichi evangelizzatori si fossero comportati così, noi non avremmo il privilegio di chiamarci cristiani. L’esempio della vita cristiana come quella di Francesco o Domenico, fondatori dei rispettivi ordini e quella dei primi apostoli è indispensabile per propagare il cristianesimo. Condanna poi quei rigidi maestri della vera religione che se ne stanno in città opulente e vengono corrotti dal lusso o se ne vanno nelle regge dei principi a caccia di guadagni censurando i passi eretici o ritenuti scismatici preferiscono comandare piuttosto che cercare di ampliare con proprio rischio i regno di Cristo.
Richiama poi a togliere la trave nel nostro occhio prima di togliere la pagliuzza nell’occhio del nostro fratello perché la fede evangelica mira a creare un modo di vita degno di Cristo. Egli infatti aiuta e tollera ciò che non è perfetto finchè non migliori. E alludendo ai vari progetti di crociata dice: “Non ci apprestiamo ad estinguere con le armi tutta l’Asia e tutta l’Africa, pur essendovi lì moltissimi cristiani e semicristiani [alludendo ai Turchi]. Perché piuttosto non cerchiamo di riconoscerli, di aiutarli e di correggerli amorevolmente?
E se poi ci sforziamo di estendere il nostro dominio, se aspiriamo a impadronirci delle loro ricchezze, perchè mascheriamo un’intenzione tanto profana mettendo avanti il nome di Cristo?”[22]. Se vogliamo -continua- vincere tramite Cristo dobbiamo usare le sue armi e quelle degli apostoli cioè la parola evangelica, la fede, la salvezza così vinceremo quanto più saremo vinti. In un altro passo si dice che anche se le armi fossero favorevoli non si diventa veramente cristiani con la violenza ed ad un cristiano ipocrita preferisce un Turco o un Giudeo sincero. Anzi con la guerra tanti buoni cristiani diventano cattivi e tanti cattivi cristiani diventano peggiori. Per Erasmo i Turchi devono avere la percezione precisa di essere invitati a salvarsi e non di essere assaliti per essere depredati e se con le parole non riusciamo ad intenderci presentiamo un modo di vita dei costumi degni del Vangelo e una professione di fede semplice e veramente apostolica, non appesantita con sottigliezze erudite.
Esamina poi le cause delle guerre tra i cristiani del suo tempo dicendo che esse sono dovute alla stoltezza ed alla malizia. Alcuni principi sono istigati da adulatori, con l’incoraggiamento di uomini di legge e di teologi e fanno guerra per temerarietà scoprendo a loro spese che essa va evitata in ogni modo. Altri invece sono spinti da odii segreti, da ambizione o dal loro carattere feroce. Sono insomma le passioni dei re e dei popoli a scatenare le guerre. Inoltre quando si fa una guerra si cerca sempre di coprire queste passioni con delle giustificazioni onorevoli: si cercano le ricchezze dei Turchi e si avanza il pretesto della difesa della religione, si seguono i propri odii e ci si giustifica col diritto, si è trascinati dall’ira o dal proprio carattere brutale e ci si inventa la scusa della rottura di un alleanza ecc.
Se ci pensiamo vediamo che anche ai nostri giorni, questo, delle giustificazioni, è un discorso ancora valido. Le cose non sono poi cambiate tanto!
Ed Erasmo continua: “Se si è attratti dal lucro, si facciano bene i propri calcoli, la guerra ci piacerà a patto di non accorgersi che un vantaggio non solo minimo, ma anche incerto, deve essere inseguito a prezzo di spese difficilmente valutabili. Si pensa allo Stato? Ma gli stati non per altra via vanno più rapidamente e più perdutamente in rovina che con la guerra…….Sarebbe doveroso che un uomo prudente considerasse tutto ciò; sarebbe doveroso che un cristiano (purchè fosse un vero cristiano) assolutamente fuggisse cercasse di allontanare, respingesse una cosa tanto infernale e tanto aliena dalla vita e dalla dottrina di Cristo.”[23]
Prosegue poi esortando a seguire Cristo nel nostro comportamento con le nostre azioni e con la nostra vita abbracciando la causa della pace perché Cristo possa riconoscerci come suoi seguaci. I pontefici, i principi, le città devono operare in questo modo. E qui esalta la figura di Leone X come colui che potrà avere più grande e vera gloria dalla restituzione della pace sulla terra. Come giustamente afferma Franco Gaeta nella sua introduzione[24], in Erasmo lo sviluppo del pensiero pacifista va di pari passo con quello del pensiero politico e religioso. Infatti, per purificazione della Chiesa, Erasmo intende l’assunzione da parte del pontificato, depurato da ogni passione di potenza e conquista territoriale della funzione di arbitro nelle contese internazionali; riforma culturale ed ecclesiastica hanno dunque un aggancio specifico e diretto, non solo con la realtà religiosa e morale dell’Europa, ma altresì con tutta la circostante realtà politico-sociale: predicazione del vangelo significa predicazione della pace e del rispetto per la persona umana, che la natura stessa ha fisicamente conformata in una prospettiva di collaborazione mutua e fattiva e che solo uno sviluppo storico ha resa oggetto e soggetto di diabolica lotta, ritorno alle fondamentali intuizioni del messaggio cristiano.
Non soltanto quindi la riforma di una teologia che si era abbassata a rissa terminologica e a contesa fra le diverse scuole, né esclusivamente la rinuncia alle liti tra le varie famiglie religiose, ma il ritrovamento nella vita religiosa di una comune armonia che serva da premessa di una comune azione pacificatrice della Chiesa. Continuando con la introduzione di Franco Gaeta i mezzi proposti da Erasmo per evitare la guerra, possono essere riassunti nell’istituto dell’arbitrato internazionale e nella rimozione di alcuni dei fattori che nel secolo XVI apparivano come i più frequenti motivi generatori di conflitti. Accanto a questi mezzi Erasmo pone anche alcuni motivi di carattere spiccatamente morale cioè la ripresa d’una vita sinceramente cristiana e quindi rientrano in una sfera meta-politica o pre-politica. Ma l’istituto dell’arbitrato internazionale è un’esigenza schiettamente politica che Erasmo non inventa, ma mutua da una ben lunga tradizione, la quale nelle condizioni storiche in cui nacque – non poteva far riferimento ad un’autorità che per definizione avrebbe dovuto essere – anche se non era effettivamente al di sopra degli interessi particolaristici degli stati.
Durante il Medio Evo tale autorità suprema garante della pace era stata individuata nell’autorità imperiale o nell’autorità pontificia; le varie soluzioni prospettate si erano sempre mosse su un piano di polemica giuridica. L’accento di Erasmo batte maggiormente su una specifica funzione del ceto ecclesiastico, del pontefice, degli uomini di cultura, cioè su un fattore non tanto di carattere giuridico, ma che si potrebbe imporre, per il proprio prestigio morale come un elemento di mediazione tra i contendenti. Come dice Franco Gaeta non si possono ridurre le cause della guerra all’egoismo ed alla ambizione dei principi, mentre prevalgono soprattutto ai nostri giorni le ragioni economiche. “Resta però valido nel pacifismo erasmiano il suo grido di protesta in nome della dignità dell’uomo, della ragione evangelica della comune sostanza umana che dovrebbe far fremere di orrore in presenza di ogni spettacolo di violenza di morte di strage.
E’ certo una protesta che “i politici” possono anche irridere; ma non è detto che l’irrisione in nome della realtà possa sempre valere quanto l’imperioso richiamo alle profondità della coscienza cui possono prestare ascolto, se non i “principi” i popoli.[25]
[1] C.f.r.Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra , a cura di Franco Gaeta 1992 L.U. Japadre Editore l’Aquila, pg. 30 - [2] C.f.r. Erasmo di Rotterdam, Contro la guerra, pg. 11 - [3]Erasmo da Rotterfam, Contro la guerra, pg. 134-135 - [4]C.f.r. Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 131 - [5] C.f.r. Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 135 - [6] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 138 - [7] Erasmo da Rotterdam Contro la guerra, pg, 138-139 - [8] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 140 - [9] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 140 - [10] C.f.r. 1 Cor., 1 e 4 - [11] C.f.r. Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 144 - [12] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 146 - [13] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 147 - [14] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 149 - [15] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 158 - [16] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 159 - [17] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 163 - [18] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 164 - [19] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg.167 - [20] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg.176 - [21] Erasmo da Rotterdam, Contro la guera, pg. 177 - [22] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 180 - [23] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, pg. 185-186 - [24] C.f.r. Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra., introduzione - [25] Erasmo da Rotterdam, Contro la guerra, introduzione,pg.51-52-53.
…continua….
Maria Rosa Mazzetti, 2025
Nella 6° puntata; 4 – Il lamento della pace
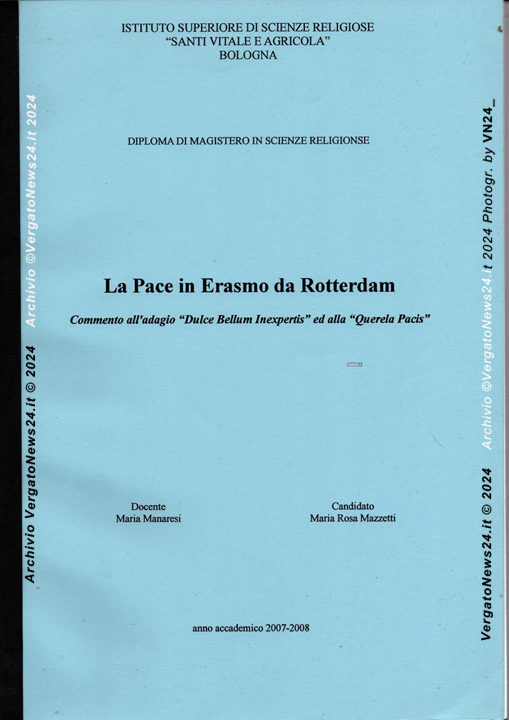
Indice; 1 – Introduzione 2 – Vita, Tematichie fondamentali della Filosofia Erasmiana e Percorso del Pensiero 3 – Adagio “DULCE BELLUM INEXPERTIS” 4 – Il lamento della pace 5 – Conclusioni – Bibliografia
Immagine copertina – https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_il_Giovane
Hai perso le puntate precedenti? Clicka qui: Puntate precedenti
